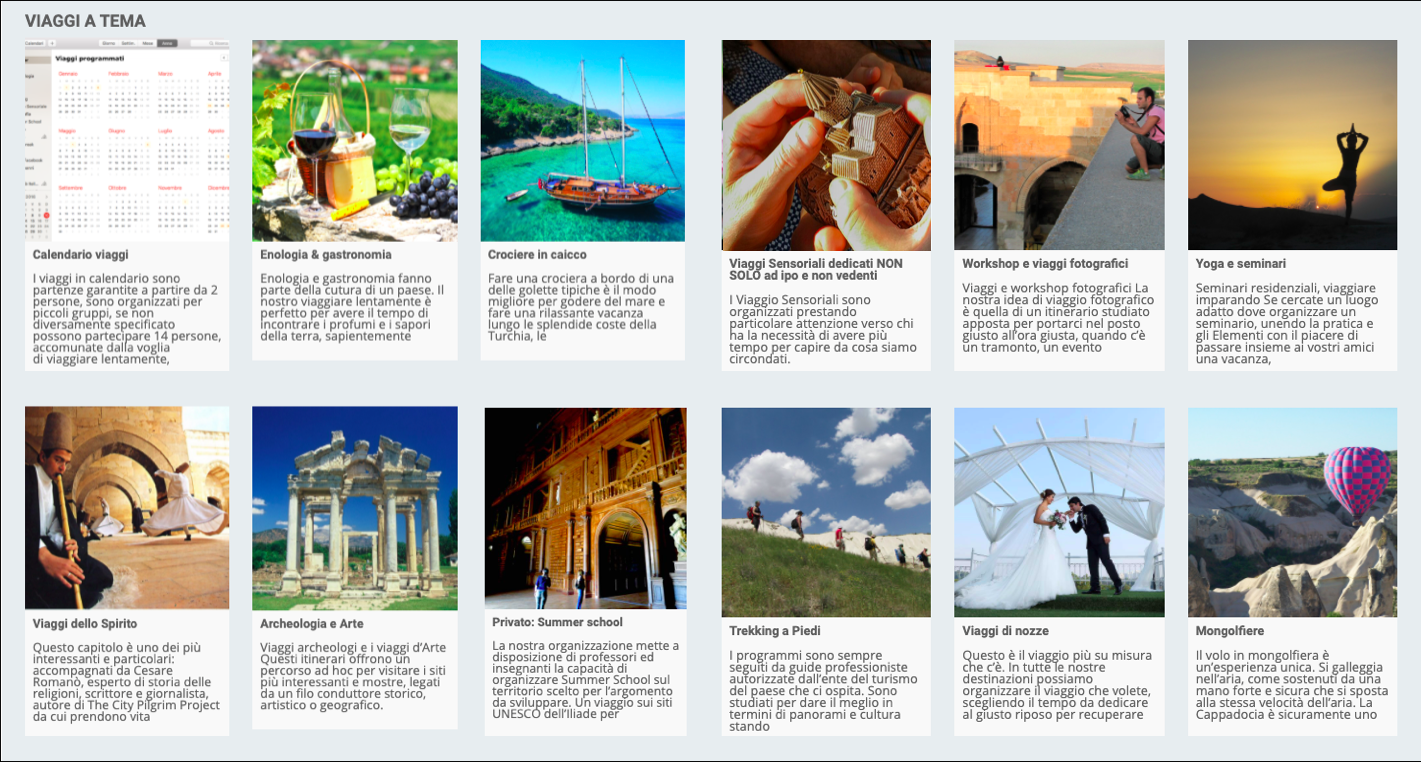Butrinto
Arrivati alla soglia del parco, ci ritroviamo al centro di un paesaggio integro: colline boscose, una laguna interconnessa con il mare tramite il canale di Vivari, praterie umide e isolotti costieri – un mosaico naturale di oltre 8.600 ettari tutelati come Parco Nazionale, Parco Ramsar e Patrimonio UNESCO. Non è solo archeologia, ma un ambiente vivo dove si incontrano più di 1.200 specie vegetali e animali – con una quindicina in pericolo di estinzione.
Dalle origini a un crocevia di culture
Immaginando le nostre prime orme sulla collina, entriamo in un sito abitato sin dal periodo preistorico. La storia di Butrinto è quella di una continua stratificazione culturale: nella Grecia antica come colonia dei Chaoni, poi città romana coloniale nel 44 a.C., fino a diventare una sede episcopale nel V secolo d.C. Nei secoli successivi spicca sotto Bisanzio, passa agli Angioini, ai Veneziani e infine agli Ottomani: ogni conquista ha lasciato tracce visibili sulle mura, sulle fortificazioni e sull’impianto urbano. La vita prosegue fino al 19° secolo, quando Ali Pascià costruisce l’ultima fortezza sul canale di Vivari, testimone di un’epoca che volge al tramonto.
La visita, passo dopo passo
- Teatro greco‑epirotaico
Entriamo nel teatro, uno dei monumenti greco‑epirotici meglio conservati: circa 1.500 posti scolpiti nella pietra, immersi nel verde. L’eco delle rappresentazioni antiche è ancora percepibile tra le gradinate.
- Foro romano e acquedotto
Camminiamo lungo il foro romano -centro della vita civile, e osserviamo i resti dell’acquedotto che attraversava la laguna reclamando paludi per espandere la città a sud del canale (come fece Augusto).
- Battistero paleocristiano
Raggiungiamo il battistero tardoromano: il pavimento musivo circolare di 14,5 m di diametro, con pavoni, cervi e simboli cristiani, ci racconta di un incontro tra arte e spiritualità del VI secolo d.C. Un’opera costruita su un edificio termale o residenziale romano: l’adattamento del passato alle esigenze della fede è affascinante.
- Basilica e mura medievali
Visitiamo la basilica paleocristiana, ricostruita nel IX secolo con tre navate e abside poligonale, ancora leggibile nella pianta; e passeggiamo lungo le fortificazioni: l’evoluzione dalle mura ellenistiche a quelle bizantine e veneziane è una lezione di storia militare.
- Il canale di Vivari e dintorni
Attraversiamo il canale di Vivari: il passaggio tra laguna e mare è scenografico. L’acqua salmastra, le fortificazioni veneziane, la torre ottomana di Ali Pascià e le attività di pesca tradizionale formano un quadro che lega natura, storia ed economia locale.
Tra natura e tutela sostenibile
Osservando gli specchi d’acqua, le rive paludose e le foreste circostanti, percepiamo la biodiversità che convive con l’eredità culturale. Il lago è una zona umida internazionale (Ramsar), vitale per specie migratorie e marine, nonché sede di molluschicoltura locale.
Il sito, dichiarato Patrimonio dell’Umanità nel 1992 e poi Parco Nazionale nel 2000, uscì dalla lista dei patrimoni in pericolo nel 2005 grazie a un modello di gestione condivisa con comunità locali, UNESCO, istituzioni e fondazioni internazionali.
Oggi è in vigore un piano di gestione integrata 2020‑2030 che punta a conciliare l’accessibilità con la tutela ambientale e culturale. È prevista la costruzione di un centro visitatori panoramico sul Vivari per orientare e coinvolgere la comunità, senza compromettere i valori propri del sito. L’UNESCO ha tuttavia avvisato sulle difficoltà legate alla gestione frammentata dei confini del sito: è essenziale evitare una governance confusa affinché Butrinto resti un esempio di tutela integrata.
Perché visitarlo oggi
Nel camminare tra rovine, vegetazione e panorami lacustri, capiamo che Butrinto è un microcosmo della storia mediterranea: dall’età preistorica fino al tardo Ottocento, ogni epoca lascia la sua impronta. Solo il 5% dell’area archeologica è esplorato sistematicamente, lasciando enormi margini per nuove scoperte. Soprattutto, capiamo che la storia di questa città non è una successione di eventi lontani, ma un dialogo continuo tra ambiente, cultura e comunità: chi lo visita comprende che la tutela culturale può essere dinamica, partecipata e inclusiva.