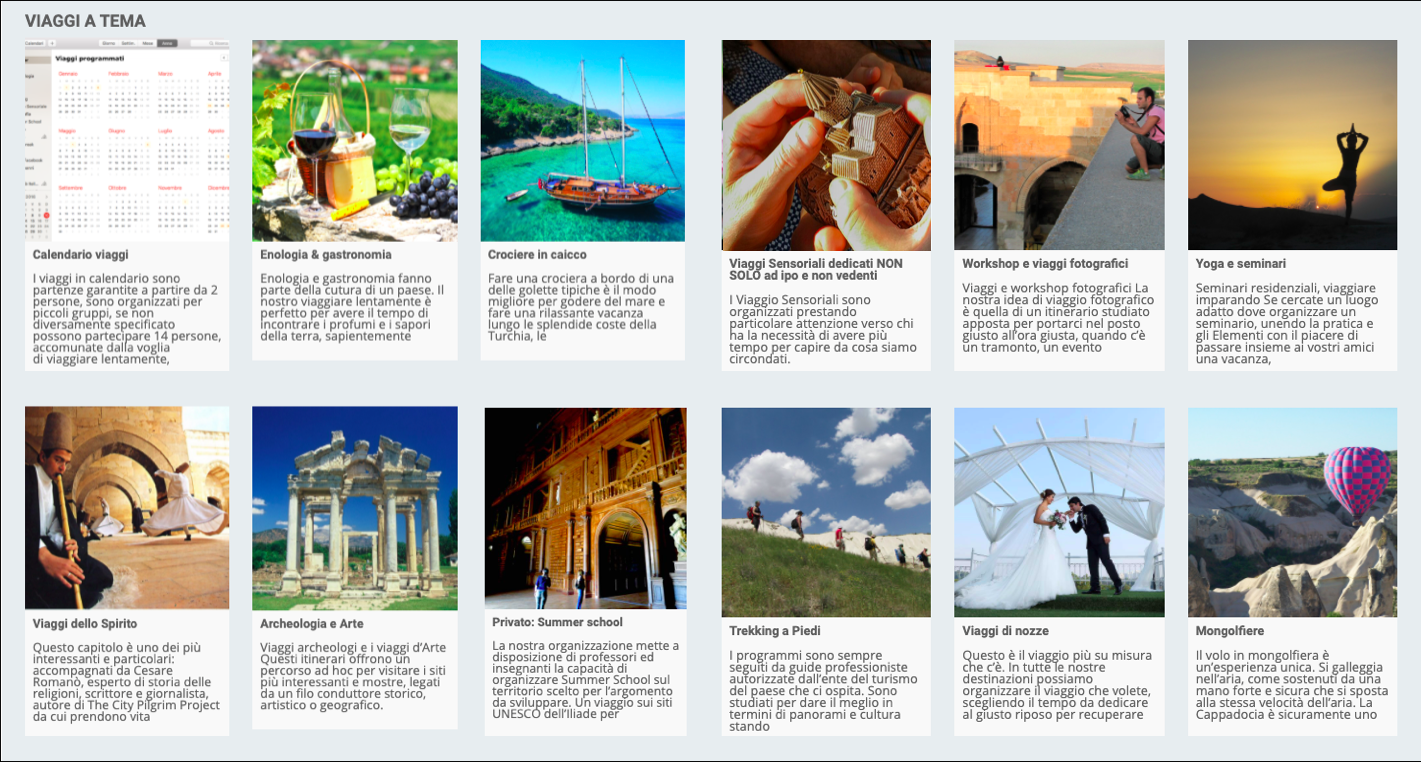Palazzo nazionale di Mafra
Un sogno in pietra per celebrare un impero
Appena ci avviciniamo al Complesso Reale di Mafra, comprendiamo subito che non siamo di fronte a una semplice residenza monarchica. Qui, il progetto voluto da re João V prende la forma di un ambizioso manifesto del potere assoluto, capace di esprimere la grandezza imperiale del Portogallo del Settecento.
L’intero complesso si articola in un palazzo reale, una basilica, un convento, la Biblioteca Reale, il giardino del Cerco e la Tapada, il grande parco di caccia. Questa visione architettonica nasce in un momento di particolare prosperità economica per il regno, alimentata in gran parte dalle ricchezze provenienti dal Brasile, e si traduce in una costruzione che ambisce a competere con le grandi opere barocche europee, soprattutto italiane.
Un architetto tedesco per un’idea romana
Passeggiando lungo la facciata, notiamo subito l’impronta internazionale dell’opera: re João V chiamò a progettare il complesso l’architetto Johann Friedrich Ludwig, un tedesco formato a Roma, scelto proprio per infondere al progetto lo spirito monumentale e solenne del barocco romano. La Basilica, fulcro simbolico dell’intera costruzione, ci appare come una dichiarazione di fedeltà estetica ai modelli papali: le sue linee e decorazioni ci ricordano le grandi chiese dell’Urbe, e la sua inaugurazione, avvenuta nel 1730 in occasione del compleanno del sovrano, ci parla di un’architettura celebrativa, costruita per eternare il ruolo divino del monarca.
La Basilica
Entrando nella Basilica, ci lasciamo avvolgere dal silenzio e dalla luce dorata che filtra dalle grandi finestre.
I nostri occhi si posano su 58 statue realizzate dai più rinomati scultori di Roma e Firenze: ogni figura sembra partecipare alla liturgia con una presenza viva. In alto, le due torri ospitano un sistema unico al mondo: due carillons, provenienti dalle Fiandre, composti da un totale di 98 campane. Accanto, ci sono i sei organi storici, capolavori della scuola organaria portoghese del tardo Settecento, costruiti per suonare all’unisono durante le grandi cerimonie.
È come se l’intero edificio fosse stato concepito per far vibrare insieme la pietra e il suono.
Il Palazzo e la Biblioteca
Camminando lungo i corridoi del palazzo, notiamo come le due torri simmetriche, pensate come appartamenti separati per il re e la regina, offrano un esempio di organizzazione architettonica inusuale per l’epoca.
La Biblioteca, situata nel cuore del convento, ci accoglie con i suoi scaffali in legno pregiato e la collezione di oltre 36.000 volumi: testi scientifici, opere filosofiche, incunaboli, e persino libri proibiti, conservati grazie a un permesso speciale. Qui ci rendiamo conto di quanto fosse centrale per il re non solo il fasto, ma anche la cultura come strumento di potere.
Una scuola di scultura tra marmo e talento
Non possiamo lasciare il convento senza soffermarci sulle pale d’altare scolpite in pietra da Alessandro Giusti, scultore italiano che fondò qui una scuola d’arte. Tra i suoi allievi troviamo Joaquim Machado de Castro, destinato a diventare il più importante scultore portoghese del XVIII secolo.
È proprio in questo cantiere monumentale che si formarono le competenze tecniche e artistiche che saranno poi decisive nella ricostruzione di Lisbona dopo il terremoto del 1755.
Il Giardino del Cerco
Proseguendo la nostra visita, ci dirigiamo verso il Giardino del Cerco, pensato inizialmente come orto e spazio di meditazione per i frati. Già nel 1718, João V ordinò che qui venissero piantati alberi provenienti da ogni angolo dell’Impero. La disposizione geometrica dei viali e delle aiuole riflette il gusto barocco per la simmetria e il controllo della natura. Al centro, un grande lago raccoglie le acque provenienti dalla Tapada, alimentato da un sistema idraulico. Una curiosità ci attende nel lato sud: un campo da gioco costruito dai Canonici Regolari di Sant’Agostino durante la loro breve permanenza nel convento tra il 1771 e il 1792.
La Tapada
Percorriamo ora i sentieri della Tapada, il grande parco forestale voluto nel 1747 per offrire alla corte un luogo di caccia, ma anche per l’approvvigionamento alimentare del convento e del palazzo. Con i suoi 1.200 ettari, la Tapada rappresenta un esempio straordinario di progettazione del paesaggio barocco, concepito come parte integrante della vita quotidiana e cerimoniale della corte. Alla fine dell’Ottocento, re Carlo I ne fece il proprio rifugio di caccia, arrivando a far costruire un padiglione per le battute reali. Ancora oggi questo spazio conserva la sua integrità ecologica e testimonia l’arte della gestione territoriale su scala monumentale.
Espressione visibile del potere assoluto
Tutto il complesso architettonico e paesaggistico di Mafra riflette con precisione la visione politica e culturale del re João V. Non si trattava solo di costruire un grande palazzo: l’obiettivo era consolidare la legittimità della dinastia portoghese, affermare la distanza dalla corona spagnola e rivendicare una prossimità con Roma, il cuore simbolico della cristianità. Ogni dettaglio – dai carillons fiamminghi agli organi lusitani, dalle statue italiane alla biblioteca enciclopedica – contribuisce a trasformare Mafra in un’opera totale, uno dei più importanti esempi di architettura barocca in Europa.
Autenticità di un monumento vivente
A distanza di quasi tre secoli, il complesso non ha subito trasformazioni che ne abbiano compromesso l’autenticità. Nonostante la fine della monarchia nel 1910 e la soppressione degli ordini religiosi nel 1834, gli spazi hanno saputo adattarsi: il convento ospita istituzioni militari, la Basilica è diventata parrocchiale, la biblioteca mantiene la sua funzione di centro di studio. Recenti restauri, come quelli degli organi e della Sala del Trono, testimoniano un’attenzione continua per la tutela del patrimonio.
Una gestione condivisa per garantire il futuro
Oggi il complesso gode di protezioni legali che ne garantiscono la salvaguardia. È classificato come Monumento Nazionale fin dal 1907 e rientra nelle normative moderne sulla tutela del patrimonio culturale. Una rete di istituzioni coordina la gestione: la Direzione Generale del Patrimonio Culturale, la Scuola delle Armi, la Tapada Nacional, il Comune e la parrocchia locale. Un protocollo di cooperazione del 2019 ha sancito l’impegno congiunto per la sua valorizzazione. Si prevede inoltre l’elaborazione di un piano di conservazione per il giardino del Cerco e per il paesaggio storico della Tapada, a garanzia della piena comprensione del sito anche per le generazioni future.