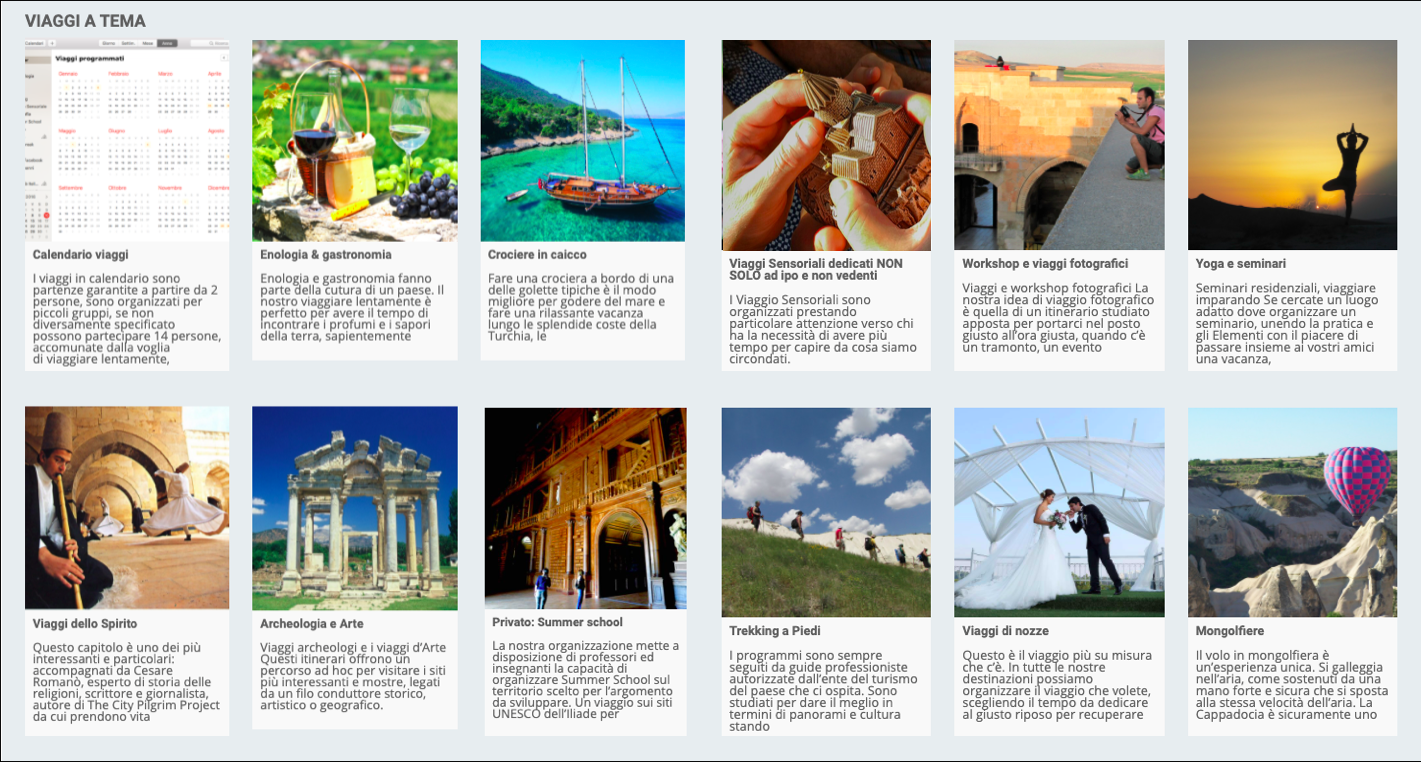L’arte dei Karagöz
Fiore all’occhiello della tradizione teatrale turca, è una forma di teatro d’ombre profondamente radicata nella cultura dell’Impero Ottomano e sopravvissuta fino a oggi come simbolo dell’identità popolare. Questo genere teatrale prende il nome dal suo protagonista più emblematico, Karagöz, il cui nome significa letteralmente “occhio nero”, e affiancato dall’inseparabile Hacivat: due figure agli antipodi, in costante e comico contrasto.
Origini leggendarie e storia
Le origini di questo teatro non sono certe, ma sono circondate da leggende affascinanti. Una delle storie più diffuse racconta che Karagöz e Hacivat fossero due muratori impegnati nella costruzione della Grande Moschea di Bursa durante il regno di Orhan I (1326–1359).
Le loro schermaglie divertivano tanto i compagni di lavoro da rallentare i cantieri, portando alla loro condanna a morte. Secondo una versione della leggenda, un certo Şeyh Küşteri creò delle marionette ispirate a loro, dando origine al teatro d’ombre come forma di rievocazione e omaggio.
Fonti scritte nel XVII secolo fanno risalire i primi spettacoli addirittura all’epoca di Bayezid I, mentre altri storici li datano al periodo della conquista ottomana dell’Egitto sotto Selim I(1512–1520).
Tecnica e scenografia
Il teatro Karagöz si basa su figure di pelle semitrasparente (chiamate tasvir) realizzate da pelle di cammello o bue, ritagliate e colorate con tinte brillanti e translucide. Le sagome, alte circa 35–40 cm, sono articolate tramite giunti mobili e mosse da bacchette sottili. Le ombre vengono proiettate su uno schermo di tessuto chiamato ayna (“specchio”), retroilluminato da una lampada ad olio. Il pubblico non vede l’animatore ma solo il gioco delle ombre, accompagnato da musica, tamburelli, canti, proverbi e poesia.
Struttura dello spettacolo
Uno spettacolo tradizionale è suddiviso in quattro atti:
- Mukaddime (Introduzione) – Hacivat apre la scena con un canto (*semai*) e una preghiera, e chiama il suo amico Karagöz.
- Muhavere (Dialogo) – Battute argute e scambi veloci tra Karagöz e Hacivat, spesso piene di giochi di parole e accenti regionali.
- Fasil (Trama principale) – L’azione si sviluppa, con l’ingresso di altri personaggi, spesso stravaganti o caricature etniche.
- Bitiş (Conclusione) – Una discussione finale tra i protagonisti in cui Hacivat rimprovera Karagöz per i pasticci combinati. Karagöz si scusa, promettendo di comportarsi meglio nel prossimo spettacolo.
Personaggi e comicità popolare
Oltre a Karagöz, uomo del popolo schietto e illetterato, e Hacivat, borghese istruito dal linguaggio forbito, lo spettacolo ospita un vasto repertorio di personaggi. A questi si aggiungono tipi etnici esagerati nei tratti e nei dialetti, il tutto contribuisce a una satira sociale e linguistica che, pur restando leggera e comica, riflette la complessità della società ottomana multietnica.
Gli Hayalî: maestri delle ombre
Il Hayalî, letteralmente “colui che dà vita alle immagini”, è l’anima dello spettacolo. Egli interpreta tutti i ruoli, modula voci e accenti, canta, suona e muove le figure. Può essere assistito da un apprendista, che gestisce le sagome, e accompagnato da un cantante e da un percussionista. Questa figura centrale incarna l’arte tramandata oralmente da maestro ad allievo, in una vera e propria scuola performativa.
Un’eredità ancora viva
Durante il periodo ottomano, il teatro Karagöz era una forma popolarissima di intrattenimento, soprattutto durante il mese sacro del Ramadan e in occasione di feste di circoncisione. Gli spettacoli si tenevano in caffè, giardini, piazze. Con l’arrivo della radio e del cinema, la sua diffusione è calata, ma sopravvive ancora oggi, soprattutto in ambienti scolastici, festival culturali, centri commerciali e sale teatrali urbane, dove continua a divertire adulti e bambini.
Più che semplice passatempo, Karagöz è un ponte culturale tra le generazioni: un’arte che unisce umorismo e riflessione, che parla di differenze e conflitti con leggerezza, e che, nell’ombra, fa brillare la luce della memoria collettiva turca.